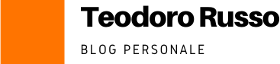La mia finestra
Osservare il mondo, soprattutto quando si è bambini o ragazzi, non è un atto passivo, dove noi siamo dei contenitori vuoti riempiti delle immagini che ci giungono dagli occhi, ma piuttosto è un’operazione creativa, durante la quale il mondo viene edificato unendo la nostra immaginazione con ciò che vediamo ”dalla finestra”.
Nel vedere oggi i ragazzi, che continuamente navigano in Internet o smanettano sul cellulare per ore e ore, mi viene naturale pensare a cosa facessi io, alla loro età, per informarmi e passare il tempo.
L’unico schermo disponibile era la televisione, primo e secondo canale RAI che, per la verità, a parte un’ora nel pomeriggio e non sempre, non trasmetteva programmi per ragazzi. Null’altro potevo fare se non documentarmi a modo mio, creando il mio personale schermo che era costituito da tutto ciò che potevo vedere e osservare. Allora non perdevo nulla di ciò che mi circondava, in qualsiasi momento e situazione. Scrutavo il mondo e imparavo.
A scuola imparavo in fretta e comunque non sono mai stato un “secchione”. Preferivo impiegare il tempo ad osservare cosa mi accadeva intorno, ciò che succedeva per la strada, a capire perché si facessero certe cose e non altre; tutte queste cose venivano da me, in un certo senso, forse per la mia visione creativa, distorte e deformate a mia immagine e somiglianza. Ed è così che immaginavo o pensavo, o pur anche sognavo, tutto ciò che non riuscivo a vedere dietro un muro di una casa, all’interno di un portone, dietro una siepe diventata improvvisamente più fitta o all’interno di uno spiazzo che non riuscivo a vedere.
Questo era il mio schermo, il mio Internet, il mio telefonino.
Guardavo tutto con attenzione perché volevo saperne di più, cercavo di capire se dietro ogni faccia di un passante, di un negoziante o di una signora, ci fosse fatica, preoccupazione o gioia per quello che stava facendo. I miei occhi meravigliati cercavano di cogliere in quei soggetti spunti incredibili di una storia. Come fosse una fiaba, filtravo ciò che mi accadeva intorno, storie quotidiane di vita che, poche volte per la verità, derubricavo come storie normali ma che, quasi sempre, cercavo di capire e immaginare.
Ero curioso insomma, anzi, molto curioso e non perché mi piacesse buttare il tempo, ma solo per soddisfare quella fame di conoscenza che, scoprii solo più tardi, era in me innata. Era, insomma, il mio guardare da una sorta di finestra sul mondo, il mio mondo fatto di cose belle e di cose brutte, interessanti o meno, che hanno contribuito in maniera indelebile alla mia formazione, alla mia crescita.
Ma dalla mia finestra lo spettacolo più grande, più interessante e che mi attraeva sempre e in ogni condizione, erano quei cantieri edili di cui non potevo fare a meno di viverli anche solo con lo sguardo, quasi con avidità. Il trasporto per le costruzioni, per la realizzazione di una casa, di un palazzo, di un ospedale, di una scuola, era fin da ragazzo per me forte, irrefrenabile; era un qualcosa a cui non potevo rinunciare.
Forse perché mio padre, operaio edile, aveva trasferito in me, la sera, inconsciamente, guardando e studiando quei progetti esecutivi che il giorno dopo in cantiere doveva realizzare, tutta la sua passione. Disegni e progetti che, piegati a fisarmonica e per me incomprensibili, guardavo e studiavo con attenzione, cercando di capire il significato di questo o quel simbolo, di questo o quel tratto di segno nero.
Ed era così che la nascita di un nuovo cantiere era per me una sorta di grande scoperta, l’inizio di una nuova avventura. I camion che transitavano in un via-vai continuo, portando via terra e rientrando carichi di materiali, la gru che girava sopra la mia testa per sollevare ogni cosa.
Il rumore della ruspa che scavava o riempiva buche e gli operai, all’inizio carpentieri o ferraioli, che con il martello e le tenaglie attaccate alla cintura dei calzoni sembravano dei veri cowboy;
poi i muratori che, d’estate in canottiera e d’inverno in ruvidi maglioni, si arrampicavano spericolati sulle impalcature. Era davvero il mio spettacolo preferito, il mio Iphone dell’epoca! Il rumore delle macchine operatrici, le grida degli operai, il loro sudore o le loro smorfie di sforzo o di stanchezza mi rapivano e, come da un moderno cellulare, non riuscivo più a distogliere lo sguardo.
Che voglia potevo avere di studiare quando avevo il mondo da guardare davanti a me che mi rapiva e appassionava ad ogni momento e ad ogni ora del giorno?
È solo più tardi, anche se solo poco più di un ragazzo, che fui costretto a viverlo direttamente il cantiere, come un semplice operaio e non più dalla finestra. Capii allora cosa volesse significare quel mondo. Compresi come era faticoso lavorare al caldo e al freddo, com’era brutto mangiare a mezzogiorno seduto su una tavola infilando il cucchiaio in una gavetta. Con la polvere di cemento o di calce che d’estate s’attaccava al sudore della pelle, con le mani tagliuzzate dal legno, dal ferro, dai mattoni.
Lo stare chinati diverse ore al giorno, sollevare pesi o battere il martello sui chiodi, per arrivare alla fine della giornata con le mani che quasi non riesci più a chiudere. Con la pioggia che bagna tutto e che, una volta cessata, rende tutto più difficile, scivoloso. Spesso, in inverno, il fango è dappertutto, in estate la polvere fin nelle orecchie.
Appresi allora che non potevo e non volevo immaginare il mio futuro così, limitarmi ad essere un semplice operaio. Dovevo far qualcosa, impegnarmi sì, in quel settore che amavo e che avevo dentro di me, ma nel contempo migliorare la mia condizione.
Il desiderarlo solamente capii, però, che non bastava a tirarmi fuori, dovevo studiare e mettere in atto tutto ciò che sul campo avevo imparato.
I libri, lo studio, sarebbero stati il mio cantiere, le mie impalcature per elevarmi, la mia gru per tirar su competenze e soddisfazioni. Il mio martello per inchiodare tutte le mie conoscenze al fine di poter gestire al meglio ogni situazione. Perché la vita è un enorme cantiere, in continua evoluzione, che quando credi di aver ultimato ti accorgi che richiede ancora molto da fare. Un cantiere non sempre facile, complesso direi, e che ora sai di non poterlo neanche immaginare guardandolo dalla finestra.
Foto: Hands off my tags! Michael Gaida da Pixabay